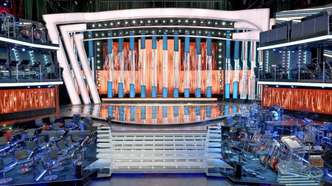L’evento astronomico più atteso del mese di agosto si prepara a illuminare i cieli notturni con uno spettacolo senza eguali. Le Perseidi, conosciute nella tradizione popolare come “stelle cadenti” o “lacrime di San Lorenzo”, raggiungeranno il loro picco di attività nella notte tra l’11 e il 12 agosto, quando sarà possibile osservare fino a 100 meteore all’ora provenienti dalla direzione della costellazione di Perseo.
Nonostante la tradizione popolare associ questo fenomeno celeste alla notte del 10 agosto, data del martirio di San Lorenzo, il picco effettivo dello sciame meteorico si verifica tipicamente tra l’11 e il 13 agosto a causa del fenomeno della precessione degli equinozi. Quest’anno, in particolare, la massima intensità è prevista tra l’11 e il 12 agosto dalle ore 22:00.
Le Perseidi rappresentano uno degli sciami meteorici più produttivi dell’anno, insieme alle Quadrantidi di gennaio, alle Geminidi di dicembre e alle Orionidi di ottobre. Il fenomeno astronomico ha origine dai detriti lasciati dalla cometa periodica 109P/Swift-Tuttle, scoperta nel 1862 dagli astronomi Lewis Swift e Horace Parnell Tuttle. Questa cometa, caratterizzata da un nucleo di circa 26 chilometri di diametro, completa la sua orbita ellittica intorno al Sole ogni 133,28 anni, raggiungendo il perielio a circa 140 milioni di chilometri dalla nostra stella per poi allontanarsi fino a 7,7 miliardi di chilometri, ben oltre l’orbita di Plutone.
Durante ogni passaggio ravvicinato al Sole, la cometa Swift-Tuttle rilascia lungo la sua orbita un gran numero di detriti solidi, le cui dimensioni variano da quelle di un granello di sabbia a quelle di un sassolino. Questi frammenti si distribuiscono nello spazio interplanetario formando filamenti di grande estensione che rimangono in orbita dove sono stati rilasciati. Ogni anno, tra il 17 luglio e il 24 agosto, la Terra attraversa questi filamenti di detriti durante il suo percorso orbitale, causando l’ingresso di meteoroidi nell’atmosfera terrestre a velocità superiori ai 200.000 chilometri all’ora.
Il fenomeno della combustione atmosferica genera le caratteristiche scie luminose che osserviamo nel cielo notturno. Le meteore Perseidi appaiono prevalentemente di colore giallo, mentre quelle più luminose risultano di colore blu. Il nome dello sciame deriva dalla costellazione del Perseo, dove si trova il radiante, ovvero il punto dal quale sembrano provenire tutte le scie meteoriche. La scoperta del legame tra le comete e gli sciami meteorici si deve all’astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli che, nel 1866, dimostrò scientificamente come l’orbita delle Perseidi coincidesse con quella della cometa Swift-Tuttle.
Per quanto riguarda le condizioni di osservazione del 2025, quest’anno presenta una situazione sfavorevole per gli appassionati di astronomia. Le Perseidi raggiungeranno il picco poco dopo la fase di Luna piena del 9 agosto, quando il nostro satellite sarà illuminato al 100%. La luminosità della Luna piena tenderà a schiarire significativamente il cielo notturno, compromettendo l’osservabilità delle meteore meno brillanti e riducendo il numero complessivo di scie visibili a occhio nudo.
Il quadrante da cui provengono le Perseidi sorgerà intorno alle 21:00-21:30 in direzione est/nord-est, ma sarà necessario attendere almeno la mezzanotte per avere la costellazione di Perseo sufficientemente alta in cielo da garantire un numero elevato di avvistamenti. Gli esperti consigliano di concentrare l’osservazione nella seconda parte della notte, indicativamente dalle 23:00 alle 4:00 del mattino, quando il radiante risulta più alto sull’orizzonte e la probabilità di osservare meteore aumenta considerevolmente.
Per ottimizzare l’esperienza osservativa, è fondamentale scegliere locazioni lontane dall’inquinamento luminoso dei centri urbani. Le zone montane, le aree rurali e le coste marine rappresentano le opzioni ideali per l’osservazione. Non sono necessari strumenti ottici particolari, poiché l’occhio nudo rappresenta lo strumento perfetto per cogliere il guizzo improvviso delle scie luminose grazie alla visione panoramica naturale. È consigliabile disporre di almeno un’ora di tempo per permettere agli occhi di adattarsi al buio e individuare più facilmente le meteore.
La tradizione culturale legata alle Perseidi affonda le radici nella storia antica. Le prime osservazioni documentate risalgono al 36 d.C. da parte di astronomi cinesi, mentre nell’antica Roma il mese di agosto era dedicato alle celebrazioni agricole e ai riti per garantire la fertilità dei campi. Il collegamento con San Lorenzo, diacono cristiano martirizzato il 10 agosto 258 d.C., ha conferito al fenomeno astronomico una dimensione spirituale e romantica che perdura fino ai giorni nostri.
Sebbene il disturbo lunare rappresenti una limitazione significativa per l’edizione 2025 delle Perseidi, gli appassionati potranno comunque assistere a uno spettacolo naturale di notevole suggestione. Le meteore più brillanti, i cosiddetti “bolidi”, rimarranno visibili anche in condizioni di cielo illuminato, lasciando scie particolarmente lunghe e luminose che possono attraversare l’intera volta celeste. Inoltre, nelle notti precedenti e successive al picco massimo, quando la Luna sarà leggermente meno luminosa, sarà possibile osservare un numero maggiore di meteore di intensità media.
Lo studio delle Perseidi continua a rivestire un’importanza scientifica considerevole per la comprensione della composizione e dell’evoluzione delle comete. I dati raccolti durante le osservazioni contribuiscono alla ricerca astronomica moderna, permettendo agli scienziati di analizzare la distribuzione e le caratteristiche dei detriti cometari nel sistema solare interno. Il fenomeno rappresenta inoltre un’occasione unica per avvicinare il grande pubblico all’astronomia, combinando il fascino della tradizione popolare con la rigorosità dell’osservazione scientifica. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!