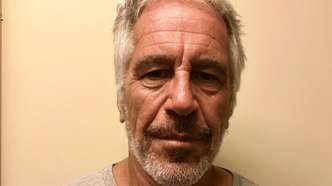L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formalmente adottato il primo Accordo Pandemico Globale della storia durante la 78esima Assemblea Mondiale della Sanità tenutasi a Ginevra, ma l’Italia ha scelto di astenersi dal voto insieme ad altri dieci paesi, rivendicando la necessità di preservare la sovranità nazionale nelle decisioni di salute pubblica. La decisione italiana, annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci, ha sollevato un acceso dibattito politico e scientifico nel paese, con l’opposizione che accusa il governo di allinearsi a posizioni isolazioniste e il mondo medico che esprime perplessità per questa scelta strategica.
Il documento approvato rappresenta il coronamento di oltre tre anni di intensi negoziati avviati dai governi in risposta agli impatti devastanti della pandemia di Covid-19, con l’obiettivo dichiarato di rendere il mondo più sicuro e più equo nella risposta a future emergenze sanitarie. L’accordo, articolato in 35 sezioni, stabilisce per la prima volta regole condivise e giuridicamente vincolanti per prevenire, prepararsi e rispondere a future emergenze sanitarie attraverso un approccio coordinato, trasparente ed equo che punta sulla collaborazione multilaterale e sulla solidarietà internazionale. Il testo definitivo è stato approvato con 124 voti favorevoli, zero contrari e 11 astensioni, ottenendo così il consenso della stragrande maggioranza degli stati membri dell’organizzazione sanitaria mondiale.
La posizione italiana è stata chiaramente esposta dal ministro Schillaci attraverso un documento ufficiale di “spiegazione del voto” depositato presso l’assemblea, nel quale si sottolinea che il punto chiave per il governo italiano rimane la tutela della sovranità degli Stati nelle questioni di salute pubblica. “Con l’astensione odierna l’Italia intende ribadire la propria posizione in merito alla necessità di riaffermare la sovranità degli Stati nell’affrontare le questioni di salute pubblica”, recita il documento ufficiale, che tuttavia riconosce alcuni aspetti positivi del testo finale. Il ministero della Salute ha precisato che l’astensione non rappresenta un voto contrario, ma piuttosto un modo per evidenziare i punti più controversi dell’accordo con l’obiettivo di migliorarlo e specificare meglio i confini dell’autorità di intervento sovranazionale dell’OMS.
Il gruppo dei paesi astenuti include nazioni dalle posizioni geopolitiche molto diverse tra loro: oltre all’Italia figurano Russia, Iran, Israele, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Giamaica, Romania, Paraguay e Guatemala. Questa composizione eterogenea ha attirato particolare attenzione degli osservatori internazionali, che hanno notato come l’Italia si sia trovata a condividere la stessa posizione di paesi con cui tradizionalmente non ha allineamenti politici significativi. L’assenza degli Stati Uniti dai negoziati, dovuta al processo di ritiro dall’OMS avviato dal presidente Donald Trump, ha ulteriormente complicato il quadro geopolitico dell’accordo, mettendo in dubbio l’efficacia pratica del trattato stesso.
Il contenuto dell’accordo definisce principi, approcci e strumenti per un migliore coordinamento internazionale in una vasta gamma di settori, con l’obiettivo di rafforzare l’architettura sanitaria globale per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie. Tra le disposizioni più significative figura l’impegno per garantire accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e strumenti diagnostici, oltre alla creazione di una rete globale per le forniture sanitarie e un meccanismo di condivisione equa dei benefici derivanti dall’uso di agenti patogeni. Il testo prevede inoltre che i produttori partecipanti destinino all’OMS il 20% dei loro vaccini, farmaci e test durante una pandemia, per garantirne l’accesso ai paesi più poveri.
Particolare rilevanza assume l’articolo 22 dell’accordo, che esplicitamente esclude qualsiasi autorità dell’OMS di imporre misure specifiche agli stati membri. “Nessuna disposizione dell’Accordo sulle pandemie dell’OMS deve essere interpretata nel senso di fornire al Segretariato dell’OMS, compreso il Direttore Generale, l’autorità di dirigere, ordinare, modificare o altrimenti prescrivere la legge nazionale o di intraprendere azioni specifiche, come vietare o accettare viaggiatori, imporre obblighi di vaccinazione o misure terapeutiche o diagnostiche o attuare blocchi”, recita testualmente il documento. Questa clausola dovrebbe teoricamente rispondere alle preoccupazioni sulla sovranità nazionale espresse da diversi paesi durante i negoziati.
Il Direttore Generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ha definito l’accordo “una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l’azione multilaterale”, sottolineando che “nessun paese deve essere lasciato solo di fronte alle minacce pandemiche”. Ghebreyesus ha inoltre evidenziato come l’accordo rappresenti “un riconoscimento da parte della comunità internazionale che i nostri cittadini, le nostre società e le nostre economie non devono essere lasciati indifesi per non patire nuovamente perdite come quelle subite durante il Covid-19”. La leadership dell’organizzazione sanitaria mondiale ha presentato il documento come uno strumento fondamentale per correggere gli squilibri e le ingiustizie emerse durante la pandemia, in particolare l’accesso diseguale a vaccini e terapie e la competizione tra stati.
La scelta italiana ha scatenato immediate reazioni critiche da parte dell’opposizione parlamentare e del mondo scientifico nazionale. Il deputato del Partito Democratico Gian Antonio Girelli, vicepresidente della commissione parlamentare d’inchiesta Covid, ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare chiedendo al governo “da che parte sta: da quello della scienza e della cooperazione internazionale nel contrastare possibili future pandemie o del più bieco oscurantismo negazionista”. Anche il Movimento 5 Stelle ha parlato di “scelta antiscientifica”, mentre Benedetto Della Vedova di +Europa ha accusato il governo di voler “esaltare il fatto che nel testo venga riaffermato il diritto sovrano degli Stati in materia di salute pubblica”.
Anche il mondo medico e scientifico italiano ha espresso perplessità per la posizione governativa. L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato che “non è un bel segnale se l’Italia si astiene sul Patto pandemico”, aggiungendo che “se sei parte dell’OMS sfilarsi su un argomento così importante ci isola da quello che è un contesto su cui dovremmo essere tutti uniti”. La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica ha definito “sorprendente” l’astensione italiana, sottolineando come essa appaia particolarmente inappropriata “alla luce delle fragilità emerse durante la recente pandemia da COVID-19”.
La questione dell’accordo pandemico si inserisce in un contesto più ampio di dibattito sulla governance sanitaria globale e sul ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle emergenze sanitarie. Mentre alcuni paesi vedono nella cooperazione multilaterale l’unica strada percorribile per affrontare minacce che non conoscono confini nazionali, altri privilegiano approcci che preservino maggiormente l’autonomia decisionale dei singoli stati. L’accordo dovrà ora essere ratificato dai parlamenti nazionali per entrare effettivamente in vigore, un processo che potrebbe richiedere tempo considerevole e durante il quale potrebbero emergere ulteriori resistenze o richieste di modifica al testo attualmente approvato dall’Assemblea Mondiale della Sanità. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!