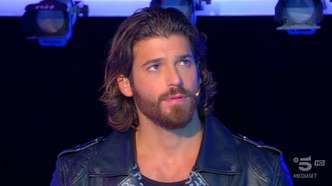Il referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno 2025 ha delineato una mappa dell’Italia profondamente divisa, con la Toscana che si conferma la regione più partecipativa registrando un’affluenza del 39,10%, mentre il Trentino-Alto Adige chiude la classifica nazionale con appena il 22,70% di votanti. I cinque quesiti su lavoro e cittadinanza promossi dalla CGIL non hanno raggiunto il quorum del 50% più uno necessario per la validità della consultazione, fermandosi a un’affluenza nazionale del 30,6%.
La Toscana ha guidato la partecipazione nazionale con il 39,10% di affluenza, seguita dall’Emilia-Romagna al 38,09% e dal Piemonte al 35,17%. La provincia di Firenze ha fatto registrare il dato più elevato in assoluto con il 46,02%, confermando la tradizionale vocazione partecipativa dell’area metropolitana fiorentina. All’interno della regione toscana, diversi comuni hanno superato la soglia simbolica del 50%, tra cui Sesto Fiorentino con il 53,01%, Pontassieve con il 51,01% e Radicondoli con il 52,62%.
L’Emilia-Romagna ha confermato la propria tradizione di elevata partecipazione democratica, con la provincia di Bologna che ha raggiunto il 47,73% per alcuni quesiti. Il comune di Anzola dell’Emilia ha rappresentato una delle rare eccellenze nazionali, superando il quorum con percentuali oscillanti tra il 50,16% e il 50,22% a seconda dei quesiti. La città di Bologna si è attestata al 47,69% per il primo quesito, mentre nelle aree dell’Appennino emiliano la partecipazione è risultata significativamente inferiore, con Castel d’Aiano che ha registrato il minimo provinciale del 29,34%.
Il centro Italia ha mostrato una partecipazione moderata ma comunque superiore alla media nazionale. La Liguria, con il 35,07%, ha superato di misura il Piemonte, mentre le Marche si sono posizionate al 32,70%. Il Lazio ha fatto registrare il 31,87%, con la capitale Roma che ha raggiunto il 36,2%, un dato superiore alla media regionale. La Basilicata, tradizionalmente considerata regione meridionale, ha sorpreso con il 31,27%, posizionandosi meglio di diverse regioni settentrionali.
L’Umbria ha registrato il 31,21%, con il piccolo comune di Paciano che ha rappresentato un’eccezione virtuosa raggiungendo il quorum con il 51,38% di affluenza. Questo dato isolato ha dimostrato come anche nelle realtà minori la mobilitazione su temi specifici possa raggiungere livelli significativi. La Lombardia, con il 30,69%, ha deluso le aspettative posizionandosi sotto la media delle regioni settentrionali.
Milano ha registrato il 36,8%, un dato superiore alla media regionale ma inferiore rispetto ad altre metropoli del Nord. Nelle province lombarde si sono registrate significative differenze territoriali, con Brescia che ha fatto segnare il 26,59% e tre elettori su quattro che hanno disertato le urne. La Valle d’Aosta, con il 29,04%, si è posizionata nella fascia intermedia della classifica nazionale, mentre il Friuli-Venezia Giulia ha raggiunto il 27,58%.
Il Sud Italia ha confermato le tradizionali difficoltà nella partecipazione alle consultazioni referendarie. La Campania, con il 29,87%, si è posizionata meglio di altre regioni meridionali, con Napoli che ha raggiunto il 33,6%. La Puglia ha registrato il 28,62%, con Taranto che ha beneficiato del traino delle elezioni amministrative per raggiungere il 34%. La Calabria ha fatto segnare uno dei dati più bassi a livello nazionale con il 23,81%, confermando le difficoltà strutturali nella mobilitazione elettorale.
Il Trentino-Alto Adige ha chiuso la classifica nazionale con il 22,70%, un dato che nasconde profonde differenze interne. La provincia di Trento ha registrato il 21,84%, mentre l’Alto Adige ha fatto segnare il record negativo nazionale del 10,3%. Bolzano ha rappresentato la provincia con l’affluenza più bassa in assoluto con il 15,9%. Queste differenze hanno riflesso le specificità linguistiche e culturali del territorio altoatesino, dove i temi del lavoro e della cittadinanza italiana assumono connotazioni particolari nel contesto di una popolazione significativamente germanofona e ladina.
Il mancato raggiungimento del quorum ha rappresentato una vittoria politica per il governo Meloni, che aveva invitato all’astensione. La premier si era recata al seggio senza ritirare le schede, una procedura che l’ha equiparata a chi non ha votato, non contribuendo quindi al raggiungimento del quorum. Il vicepremier Tajani ha commentato il risultato come “una sconfitta della sinistra e dell’opposizione che voleva tentare l’assalto al governo utilizzando il grimaldello dei referendum”.
Le opposizioni hanno interpretato diversamente i dati, con il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia che ha sottolineato come “hanno votato 15 milioni di persone”, un numero superiore ai 12,3 milioni di voti ottenuti da Giorgia Meloni alle politiche del 2022. Pina Picierno del Pd ha definito il risultato “una sconfitta profonda, seria, evitabile” e “un regalo enorme a Giorgia Meloni e alle destre”.
Il confronto con precedenti consultazioni referendarie ha evidenziato il progressivo calo della partecipazione. Nel 2011, quando si votò sui referendum sull’acqua pubblica, l’affluenza finale raggiunse il 57%, superando il quorum. Nel 2022, i referendum sulla giustizia registrarono un’affluenza del 20,4%, fallendo anch’essi il raggiungimento del quorum. La distribuzione geografica del voto ha confermato tendenze consolidate, con il Centro-Nord che mantiene livelli di partecipazione democratica superiori al Mezzogiorno, evidenziando come sussistano ancora significative differenze territoriali nella mobilitazione civica italiana. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!