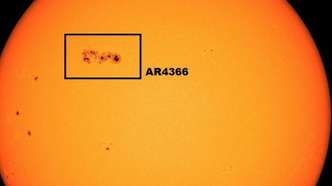L’oceano Atlantico settentrionale, nella vasta distesa d’acque che lambisce le coste orientali del Canada, ha recentemente restituito un enigma di dimensioni colossali: un iceberg dal colore eccezionalmente scuro, quasi nero, è stato avvistato al largo del Labrador. La sua comparsa ha suscitato immediata curiosità tra i ricercatori marini e gli esperti di glaciologia, gettando nuova luce su processi naturali tuttora poco compresi. Il gigantesco blocco di ghiaccio, stimato in centinaia di metri di diametro, fluttua al largo di Cape St. John, attirando le attenzioni di navi scientifiche e satelliti d’osservazione, che ne monitorano i movimenti e ne raccolgono immagini dettagliate.
Il fenomeno non è mai stato documentato con tale nitidezza: iceberg usualmente appaiono bianchi o azzurri, riflettendo la luce solare secondo la tradizionale teoria della diffusione Rayleigh. Il nero, invece, suggerisce un’assorbimento intenso della radiazione solare, condizione che potrebbe accelerare lo scioglimento superficiale e alterare l’assetto termico del blocco. Per comprendere le origini di questo insolito colore è stato attivato immediatamente un protocollo di indagine interdisciplinare, che coinvolge oceanografi, geologi, vulcanologi e, sorprendentemente, astrofisici.
Le prime ipotesi formulate puntano sui detriti glaciali, ovvero polveri e frammenti rocciosi trasportati all’interno dei ghiacciai continentali e concentratisi durante il crollo di una seraccata. Tuttavia, non tutte le teorie trovano pieno riscontro nei campioni raccolti in loco, dove si registrano basse concentrazioni di silice e feldspato, minerali tipici del substrato roccioso groenlandese. Alternative più suggestive parlano di cenere vulcanica: la nube espansa durante l’eruzione di un vulcano islandese, avvenuta nel 2023, potrebbe essersi depositata sulla superficie dei ghiacciai, restando intrappolata al loro interno e tingendo di scuro la massa ghiacciata una volta trasportata in mare. Recenti analisi granulometriche hanno individuato particelle finissime di ossidi metallici, compatibili con materiale piroclastico, ma ancora carenti per stabilire con certezza questa provenienza.
All’interno del gruppo di ricerca, coordinato dal Dr. Émile Fournier dell’Università di Montréal, non si esclude neppure un’origine cosmica. Particelle di polvere interstellare o micrometeoriti, discioltesi nel ghiaccio millenario, potrebbero averne modificato la colorazione. Tale ipotesi trae fondamento dalla presenza di tracce di metalli rari, come il iridio e il platino, rinvenute in concentrazioni superiori allo standard geochimico marino, suggerendo un apporto extraterrestre. Tuttavia, la natura effimera delle particelle cosmiche e la loro diffusione irregolare rendono complicato stabilire un nesso diretto con l’aspetto visivo dell’iceberg.
Strumenti radar a banda larga installati su satellite hanno misurato lo spessore del blocco ghiacciato, attestandolo sui quaranta-settanta metri nel punto di massima profondità, mentre rilievi batimetrici hanno stimato un peso complessivo superiore a venti milioni di tonnellate. La strana colorazione superficiale, concentrata in strisce e macchie, non è uniforme: zone di ghiaccio candido si alternano a lunghi solchi scuri, quasi fessure che rivelano lacune di densità e composizione. Il pattern suggerisce processi di fusione differenziati, alimentati da bolle d’aria intrappolate e da gradienti termici localizzati.
Le missioni di campionamento, condotte da imbarcazioni rompighiaccio, hanno prelevato decine di litri d’acqua di fusione e frammenti di ghiaccio, che ora sono oggetto di analisi spettroscopica nei laboratori del Centre Eau Terre Environnement di Québec. Si intendono determinare le firme isotopiche degli elementi presenti e ricostruire l’avventura di questi materiali, dalla loro origine fino all’approdo nel Golfo di San Lorenzo. L’esame dei rapporti isotopici dell’ossigeno e dell’idrogeno fornirà dati preziosi sulla temperatura di formazione del ghiaccio, mentre la spettrometria di massa potrà confermare o escludere la presenza di materia vulcanica o cosmica.
Nel frattempo, studi sul campo indicano che l’iceberg nero potrebbe rappresentare un nuovo modello di ghiacciaio mobile, sfidando le classificazioni tradizionali di iceberg tabulari e a cuneo. Se confermata, questa categoria aggiuntiva potrebbe aiutare a spiegare alcuni casi di scioglimento accelerato osservati negli ultimi anni lungo le coste della Groenlandia e dell’Islanda, dove proliferano depositi superficiali di polvere e cenere. Il fenomeno potrebbe tradursi in un feedback positivo: l’iceberg più scuro assorbe maggior calore solare, si scalda più in fretta, perdendo integrità strutturale e rilasciando nuove particelle di detrito.
Le implicazioni ambientali sono molteplici: una maggiore velocità di fusione potrebbe accelerare l’innalzamento del livello del mare, con conseguenze su ecosistemi costieri e infrastrutture antropiche. Nel frattempo, lo Studio Oceanografico Atlantico, con sede a Halifax, ha avviato un monitoraggio delle correnti di marea per valutare la dispersione delle particelle scure nell’acqua circostante e il loro impatto sulla temperatura locale. Esperimenti condotti in vasca presso l’Instituto Oceanográfico di Lisbona stanno simulando la fusione di ghiaccio misto a cenere, al fine di quantificare l’assorbimento radiativo e misurare la velocità di disgregazione del blocco.
L’enigma dell’iceberg nero al largo del Labrador si pone dunque come un caso di studio unico, capace di integrare conoscenze di glaciologia, vulcanologia, oceanografia e persino astrofisica. Mentre scienziati di diverse discipline collaborano per svelarne l’origine, l’evento contribuisce ad arricchire la comprensione delle dinamiche polari e delle interazioni tra ghiaccio, atmosfera e superficie marina. L’iceberg oscuro, quasi scolpito in un marmo notturno su un palcoscenico oceanico, ci ricorda che l’ambiente artico e subartico conserva ancora segreti inediti, sollecitando un approccio multidisciplinare e un monitoraggio costante in un contesto di cambiamenti climatici in rapida evoluzione.
Ancora non è dato sapere se altri iceberg neri emergeranno lungo le rotte delle correnti fredde, né se l’iniziazione del fenomeno sia legata a un evento geologico isolato o a processi ciclici di lunga durata. Le prossime campagne di esplorazione e i dati raccolti da boe oceanografiche e droni subacquei forniranno informazioni essenziali per rispondere a questi interrogativi. Nel frattempo, l’immagine di un iceberg nero, su cui si riflettono le tonalità cupe dell’inverno artico, rimane scolpita nell’immaginario scientifico come testimonianza della complessità e della meraviglia del nostro pianeta. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!