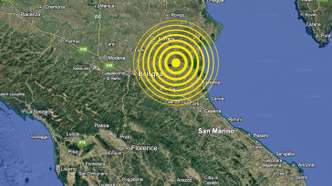Il Tribunale dell’Unione europea ha inferto un duro colpo alla Commissione guidata da Ursula von der Leyen, annullando la decisione di negare l’accesso ai messaggi di testo scambiati tra la presidente e l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, durante le negoziazioni per l’acquisto dei vaccini anti-Covid. La sentenza, emessa questa mattina a Lussemburgo, rappresenta una vittoria significativa per la trasparenza istituzionale e accoglie il ricorso presentato dal New York Times, che si era visto negare la possibilità di consultare questa corrispondenza ritenuta cruciale per comprendere i dettagli dei negoziati che hanno portato al più grande contratto vaccinale della storia europea.
Il caso, noto ormai come “Pfizergate”, ha messo in luce le modalità con cui la Commissione europea ha gestito l’acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Pfizer per un valore di circa 20 miliardi di euro, nell’ambito di un piano complessivo che ha visto l’UE acquistare in totale 4,2 miliardi di dosi vaccinali. La controversia si è concentrata sulla legittimità del rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di accesso a tutti gli SMS scambiati tra von der Leyen e Bourla nel periodo compreso tra gennaio 2021 e maggio 2022, quando si definirono i termini dell’accordo.
La sentenza del Tribunale: “Illegittimo negare l’accesso”
Nella sua pronuncia, il Tribunale UE ha ricordato che il regolamento relativo all’accesso ai documenti mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti in possesso delle istituzioni europee e che, in linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. I giudici hanno ritenuto che le risposte fornite dalla Commissione europea durante l’intero procedimento “si basano o su ipotesi, oppure su informazioni mutevoli o imprecise”.
Il ricorso era stato presentato dalla giornalista Matina Stevi e dal quotidiano americano New York Times, che avevano chiesto l’accesso ai messaggi nell’ambito di un’indagine giornalistica sulla trasparenza delle contrattazioni europee per l’approvvigionamento vaccinale. La Commissione aveva respinto la richiesta sostenendo di “non essere in possesso” dei documenti oggetto della domanda, una giustificazione che il Tribunale ha ritenuto insufficiente e non plausibile.
“Al contrario”, hanno sottolineato i giudici, “la signora Stevi e il New York Times hanno presentato elementi pertinenti e concordanti che descrivono l’esistenza di scambi, in particolare sotto forma di messaggi di testo, tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer nell’ambito dell’acquisto di vaccini durante la pandemia di Covid-19”. Tali elementi hanno permesso di “superare la presunzione di inesistenza e di non possesso dei documenti richiesti”.
Il contesto del Pfizergate e le implicazioni politiche
Il caso è emerso per la prima volta nell’aprile 2021, quando il New York Times rivelò che von der Leyen aveva personalmente negoziato l’accordo con Pfizer attraverso una serie di messaggi e telefonate con Bourla. Una strategia descritta come “un allineamento sorprendente tra la sopravvivenza politica e l’intraprendenza aziendale”. Tale approccio sollevò immediatamente preoccupazioni sulla trasparenza del processo decisionale, soprattutto considerando l’entità economica dell’accordo e l’importanza strategica della fornitura vaccinale in piena emergenza pandemica.
La controversia si inserisce in un quadro più ampio di indagini e contestazioni: già ad aprile 2024 era emerso che la Procura europea (EPPO) stava indagando sui messaggi tra von der Leyen e Bourla per possibili accuse di “interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interessi”. L’indagine, inizialmente avviata dalle autorità giudiziarie belghe di Liegi all’inizio del 2023 dopo una denuncia presentata dal lobbista Frédéric Baldan, era successivamente passata alla competenza dell’autorità giudiziaria europea.
Nonostante le pressioni, la Commissione europea aveva fino ad oggi rifiutato di rivelare l’esistenza o il contenuto degli SMS, arrivando a derubricarli come comunicazioni non rilevanti, prive di contenuti sostanziali ai fini della stipula del contratto. Secondo la difesa di Bruxelles, “i messaggini servivano solo per velocizzare la comunicazione” e “non erano uno strumento politico né utile alla definizione di politiche e contratti”.
La trasparenza in discussione
Il nodo centrale della questione riguarda la definizione stessa di “documento ufficiale” e i limiti della trasparenza nelle istituzioni europee. Nella sua sentenza, il Tribunale ha enfatizzato che la Commissione non ha chiarito adeguatamente se i messaggi di testo richiesti siano stati cancellati e, in caso affermativo, se la cancellazione sia avvenuta deliberatamente o automaticamente. In ogni caso, ha precisato la Corte, l’istituzione “non può limitarsi ad affermare di non essere in possesso dei documenti richiesti, ma deve fornire spiegazioni credibili che consentano sia al pubblico che alla Corte di capire perché tali documenti non possono essere reperiti”.
La vicenda richiama un precedente controverso nella carriera di von der Leyen: come riportato nelle indagini, la presidente aveva già utilizzato il suo telefono per assegnare contratti del valore di diverse centinaia di milioni di euro durante il suo mandato come ministro della Difesa tedesco, di fatto aggirando i processi di appalto pubblico. In quell’occasione, aveva successivamente cancellato tutti i messaggi dal suo telefono quando gli investigatori avevano avviato indagini.
La questione solleva interrogativi fondamentali sulla responsabilità istituzionale e sulla trasparenza nei processi decisionali europei, soprattutto quando coinvolgono somme ingenti di denaro pubblico e decisioni strategiche in contesti emergenziali. Come sottolineato da diversi osservatori, se da un lato la pandemia ha richiesto decisioni rapide e canali di comunicazione efficienti, dall’altro la natura democratica dell’Unione esige che tali processi restino verificabili e accessibili ai cittadini.
Le reazioni e le prospettive future
La sentenza è già stata definita da alcuni come “storica” per le sue implicazioni sul diritto all’informazione e sull’accountability delle istituzioni europee. Il pronunciamento arriva in un momento particolarmente delicato per la leadership di von der Leyen, che si trova al suo secondo mandato alla guida dell’esecutivo comunitario.
La decisione del Tribunale potrebbe avere ripercussioni significative anche sulle indagini in corso della Procura europea, fornendo nuovi elementi per l’accertamento di eventuali responsabilità. Fino ad ora, secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, nessuno è stato ancora formalmente accusato in relazione al caso, ma le indagini proseguono.
La Commissione europea, che prima della sentenza aveva dichiarato che “questi contratti erano totalmente senza precedenti in un contesto totalmente senza precedenti”, dovrà ora riconsiderare la propria posizione e potenzialmente rendere accessibili documenti finora tenuti riservati. Una svolta che potrebbe non solo fare luce sui dettagli della trattativa con Pfizer, ma anche stabilire un importante precedente per la trasparenza delle comunicazioni istituzionali nell’era digitale, dove la distinzione tra comunicazioni formali e informali diventa sempre più sfumata.
La vicenda del Pfizergate, lungi dall’essere conclusa, si conferma così come un caso emblematico del difficile equilibrio tra efficienza decisionale, tutela degli interessi commerciali e diritto all’informazione, in un’Unione europea che continua a cercare il proprio assetto istituzionale tra esigenze di rapidità operativa e necessità di controllo democratico. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!