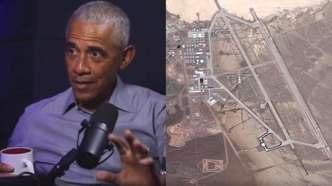L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento della Protezione Civile concordano nel descrivere la penisola come un mosaico di aree ad elevata pericolosità sismica, concentrate lungo l’arco appenninico, sul margine alpino orientale e nell’estremo Meridione, dove la convergenza fra placca euro-asiatica e microplacca adriatica genera deformazioni crostali continue. In base alla classificazione nazionale il picco di accelerazione atteso (PGA) oltre 0,25g identifica la Zona 1, ossia la fascia di massima pericolosità che include 708 comuni distribuiti in una decina di province chiave.
Nel Mezzogiorno primeggiano le province di Reggio Calabria e Messina, gemelle geologiche affacciate sullo Stretto. Il ricordo più drammatico è legato al sisma del 28 dicembre 1908, magnitudo Mw 7.1, che in soli trentasette secondi cancellò gran parte dei due capoluoghi e innescò uno tsunami con onde superiori a dieci metri; le vittime furono circa 80.000. L’evento, oltre a rappresentare la massima catastrofe naturale europea in epoca storica, determinò l’introduzione della prima classificazione sismica nazionale e pose le basi della moderna normativa antisismica.
All’interno dell’Appennino meridionale spicca la provincia di Avellino, epicentro del terremoto dell’Irpinia del 23 novembre 1980. La scossa di Mw 6.9, durata novanta secondi, devastò 679 municipi tra Campania e Basilicata, causò circa 2.900 morti e 280.000 sfollati e raggiunse l’intensità X della scala Mercalli. Il bilancio economico superiore a 59 miliardi di lire dell’epoca spinse il legislatore a rafforzare la pianificazione territoriale e a istituire la Protezione Civile come struttura operativa permanente.
Spostandosi nell’Appennino centrale, la provincia de L’Aquila rappresenta un laboratorio di rischio per la tectonica distensiva che accomuna l’intera dorsale. Il 6 aprile 2009 una rottura di Mw 6.3 a 9,5 km di profondità produsse intensità Mercalli X, 309 vittime e oltre 66.000 senza tetto, con un danno diretto stimato in 16 miliardi di dollari. La disomogeneità del tessuto edilizio, caratterizzato da murature storiche accanto a costruzioni recenti prive di adeguate prescrizioni, amplificò le perdite e mise in evidenza il ruolo della microzonazione sismica a scala di quartiere.
In area alpina la provincia di Udine è la più esposta, come ricorda il terremoto del 6 maggio 1976, Mw 6.5, che distrusse Gemona, Venzone e altri settantasette paesi, provocando 990 morti e oltre 157.000 senza casa. Il sisma friulano, generato dalla spinta della microplacca adriatica contro il margine sud-alpino, dimostrò l’efficacia di un modello di ricostruzione basato su forte decentramento amministrativo e partecipazione comunitaria, ancora oggi indicato come best practice.
Anche la Pianura Padana orientale, pur percepita a lungo come area a bassa sismicità, include province classificate Zona 2 al limite con la Zona 1, come Modena e Ferrara. La sequenza emiliana del maggio 2012, con due eventi principali di Mw 5.9 e 5.8 il 20 e 29 maggio, causò 27 vittime, più di 350 feriti e danni diffusi al patrimonio monumentale e al tessuto industriale della bassa modenese. Le ripercussioni economiche superarono i 500 milioni di euro e resero evidente l’importanza della progettazione sismica anche per strutture produttive e capannoni.
Lungo l’asse ionico-tirrenico calabrese il 2024 ha visto la provincia di Cosenza protagonista di un sisma di magnitudo 5 che, pur senza effetti distruttivi, ha riacceso l’attenzione su un tratto di arco calabro soggetto a subduzione della placca ionica e frequenti sequenze a medio fondale. Più a sud, la provincia di Reggio Calabria resta l’epicentro potenziale di eventi di magnitudo superiore a 7 per la presenza di faglie attive sottomarine che allineano la sismicità storica dal 1783 al 1908.
La dorsale umbro-marchigiana conferma la vulnerabilità della provincia di Perugia, colpita il 26 settembre 1997 da una coppia di eventi Mw 5.7 e Mw 6.0 che lesionò la Basilica di San Francesco ad Assisi e altri capolavori medievali, con 11 vittime e migliaia di sfollati. Il cantiere di restauro della volta affrescata dimostrò quanto la perdita di patrimonio culturale possa amplificare il costo sociale di un terremoto.
| Provincia | Classe di rischio (PGA) | Evento emblematico | Magnitudo | Anno |
|---|---|---|---|---|
| Messina | Zona 1 | Stretto di Messina | 7.1 | 1908 |
| Avellino | Zona 1 | Irpinia | 6.9 | 1980 |
| L’Aquila | Zona 2 | Appennino centrale | 6.3 | 2009 |
| Udine | Zona 2 | Friuli | 6.5 | 1976 |
| Modena | Zona 2 | Pianura padana emiliana | 5.9 | 2012 |
| Cosenza | Zona 1 | Sequenza ionica | 5.0 | 2024 |
A livello nazionale le province classificate in Zona 1 e 2 sommano oltre 21,5 milioni di residenti, con densità edilizia spesso elevata in aree urbanizzate prive di omogenea cultura della prevenzione. La continuità degli sciami recenti dimostra che la pericolosità non è un retaggio del passato ma una componente permanente del territorio: il 2024 ha registrato 16.826 eventi localizzati, pari a 46 scosse al giorno. Tale frequenza obbliga le amministrazioni provinciali ad aggiornare periodicamente le microzonazioni, a incentivare interventi di adeguamento strutturale e a promuovere piani di emergenza che tengano conto tanto dell’esposizione demografica quanto della vulnerabilità degli edifici storici.
In conclusione, Messina, Reggio Calabria, Avellino, L’Aquila, Udine, Modena, Ferrara, Cosenza e Perugia costituiscono un nucleo di province che la storia sismica e la zonazione ufficiale indicano come prioritarie per politiche di mitigazione. Il passato testimonia la violenza potenziale, il presente conferma la persistenza dell’attività tettonica e il futuro dipenderà dalla rapidità con cui cittadini, professionisti e istituzioni tradurranno la consapevolezza del rischio in scelte pianificate e investimenti strutturali. Per restare sempre aggiornato scarica GRATIS la nostra App!